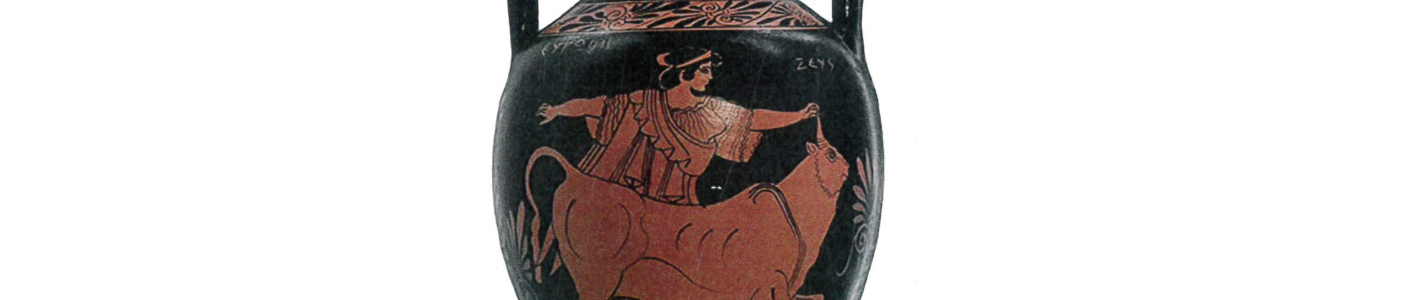Il comprensorio archeologico della antica città romana di Minturnae, ancora oggi solo parzialmente riportata alla luce, si estende su 5 ettari ed è a circa due chilometri dall’attuale foce del fiume Garigliano, già centro nevralgico geografico e militare in epoca preromana, per essere stata a lungo uno snodo di passaggio delle vie di comunicazione tra i monti dell’attuale Ciociaria e la Campania.

La città, edificata dai romani nel 295 a.C. sulle rovine della preesistente città aurunca, e dagli stessi distrutta per aver parteggiato per i Sanniti, è compresa nel comune di Minturno, in provincia di Latina, e rappresenta una delle più importanti testimonianze storiche e archeologiche del Sud pontino. Minturnae, infatti, era la quarta città romana per importanza e per abitanti dell’Italia antica, famosa per i suoi cantieri navali alimentati con il legno e la pece che provenivano dalla fitta foresta di conifere che sorgeva sulle colline retrostanti.
Città ad elevata valenza residenziale anche per la fertilità dei suoli e per la mitezza del clima. Del più antico impianto della Colonia si conserva il circuito delle mura del castrum in pianta quadrata, con un lato appoggiato alla riva del fiume, ove successivamente venne costruito un ponte, il Pons Tirenus, ricordato da Cicerone.

L’assetto urbanistico arrivato sino a noi, dopo la primitiva colonizzazione in epoca repubblicana, fu ampliato da due nuovi insediamenti all’epoca di Cesare e poi di Augusto, che vi impressero grande sviluppo. Centro commerciale e di intensi traffici, grazie al porto e al fiume navigabile, con la monumentalizzazione delle sponde in corrispondenza della città, su cui venivano trasportati i prodotti di una terra ferace. Sulle vicine colline furono edificate imponenti ville rustiche che costellavano le rive del Garigliano fino alle gole di Suio, già famosa per essere ricchissima di acque minerali salutari.
Minturnae era una delle città della costa tirrenica più frequentata dalle famiglie della nobiltà romana, che vi edificarono sontuose domus e residenze marine, i cui resti sono ancora oggi in gran parte tutti da esplorare e studiare. L’antica città era anche servita da un importante acquedotto, lungo 11,400 km,
che attingeva dalle vicine sorgenti di Capodacqua, costruito nei primi decenni del I secolo a.C., e le cui eleganti arcate ancora punteggiano la piana minturnese. Dopo la caduta dell’impero romano d’Occidente, anche la città di Minturnae decadde fino a quando fu completamente devastata attorno al 580 d.C., all’epoca dell’occupazione dei Longobardi.

A loro, sembra, si deve anche la parziale distruzione dell’acquedotto cittadino, che finì per impaludare l’intera zona, anche se già in parte allagata in epoca repubblicana, che ne decimò la popolazione esistente, che fu costretta a trovare rifugio sull’altura dove sorge l’attuale Minturno (Traetto fino al 1879). Fu proprio questo fenomeno di sommersione a proteggere gli edifici più importanti della città, che comunque subì nel corso dei secoli numerose distruzioni e furti di materiali, in parte poi riutilizzati in nuove costruzioni, come era d’uso al tempo, e che ancora oggi possiamo osservare, tra l’altro, in alcune chiese della stessa Minturno e di Gaeta. Verso il X secolo d.C. la città, ormai quasi del tutto abbandonata, ospitò per lungo tempo una colonia di Saraceni, che da qui partivano per le loro incursioni sulle coste del sud Lazio e le isole.
L’attuale area archeologica confina con la Via Appia, con via Punta Fiume, con il Cimitero Inglese e con alcuni terreni di privati agricoltori utilizzati a serre. L’insieme ha come cornice che l’arricchisce da una parte a circa due chilometri verso la foce del Garigliano, i resti dell’antico tempio sacro, dedicato alla ninfa Marica, divinità che presiedeva alla natura selvaggia, risalente al VI secolo a.C., e tra i più antichi del Lazio; dall’altra il ponte Real Ferdinando voluto da Ferdinando II Borbone e fatto realizzare nei pressi di un precedente ponte ligneo di età romana, di cui negli anni ottanta del novecento furono rintracciati i resti dei piloni lignei.

Va anche ricordato che nei pressi e nell’alveo de Garigliano, furono, poi, rinvenuti un gran numero di monete di varie epoche, che vanno dal VI secolo a.C. agli anni della tarda romanità, e che formano una delle raccolte più preziose dell’ Antiquarium minturnese. Il Real Ferdinando, vera e grande impresa del tempo, è il primo ponte sospeso su catenarie in ferro dell’Europa continentale, realizzato tra il 1828 e il 1832, su progetto dell’Ing. Luigi Giura. Le sue catene a maglie furono costruite nella ferriera Filangieri di Candida, installata nel 1824 da Carlo Filangieri di Satriano a Razzona di Cardinale, testimonianza rilevante dell’alto livello raggiunto dalle industrie del Regno borbonico. In antico le comunicazioni nella zona erano assicurate da una viabilità principale, costituita dalla Via Appia, dalla via Pedemontana e dalla via che correva lungo il fiume, e da una viabilità secondaria, con numerosi attraversamenti anche essi rifiniti a basolati sia nella zona costiera che in quella interna. L’economia della città, fondata come colonia marittima, si basava essenzialmente, come già ricordato, sul porto e sulle attività connesse dei cantieri navali, e sul commercio di quanto era prodotto nel territorio. Le
testimonianze storiche e archeologiche documentano l’immagine di una città attiva e cosmopolita, come altre città con porti affacciati sul Mediterraneo.
Dopo l’abbandono di secoli, la riscoperta e lo scavo della città antica iniziò solo nell’Ottocento e si deve al generale Laval Nugent, Comandante delle truppe napoletane. Furono recuperati molti reperti, senza criteri scientifici, del resto al tempo non ancora sviluppati. Vennero riportati alla luce oltre 150 statue che, trasferite prima a Venezia, poi a Trieste, furono alla fine ceduti al Banato di Zagabria, dove oggi sono conservati ed esposti nel Museo Nazionale Archeologico della stessa città. Oltre ai gruppi marmorei di pregio, furono venduti anche sarcofagi, colonne, ed alcune iscrizioni. Nello stesso tempo molti altri preziosi ritrovamenti presero la via di Napoli e di Roma, quando non furono oggetto di furti e offerti sul mercato clandestino nazionale e straniero. Purtroppo anche negli ultimi decenni abbiamo assistito ad altri gravi guasti e a manomissioni e sottrazioni che hanno ulteriormente spoliato l’area.
Esplorazioni regolari e scientifiche furono iniziate solo nel 1931 dall’ University of Pennsylvania di Philadelphia per iniziativa del Conte Costantini, Presidente dell’Associazione Internazionale di Studi Mediterranei e sotto la direzione dell’archeologo americano Prof. Jotham Johnson. Gli scavi si concentrarono soprattutto sull’antico Castrum e sul c.d. Foro Repubblicano, il c.d. Foro Imperiale e il massimo asse viario urbano corrispondente alla Via Appia, che qui segnava il XCVIII miliario da Roma e
sull’imponente Teatro, capace di ben 5.000 spettatori. È superfluo ricordare che parte di quei ritrovamenti presero, come era del resto stato concordato, in compensazione del costo degli scavi, la via d’oltreoceano, finendo nel Museo dell’Università di Pennsylvania. Quel che è certo è che oggi parte dell’antica città romana attende ancora una completa campagna archeologica, procrastinata a causa delle scarse risorse disponibili che non permettono di acquisire i terreni oggi in mano a privati e spostare il contiguo cimitero inglese.

Tra le testimonianze già individuate, ma non ancora esplorate vi è, tra l’altro, un imponente anfiteatro.
Negli ultimi decenni molti sono stati i tentativi di dar corso ad una vasta e completa campagna di scavo ma, ad esclusione di singole iniziative, ancora senza esito. Tra le personalità culturali più attive nella valorizzazione dei resti cospicui di una delle maggiori città romane ci fu il Professor Pietro Fedele, minturnese e anche ministro della Pubblica Istruzione (dal 1925 al 1928) che, nel 1929, raccolse molti manufatti provenienti dal sito, raccogliendoli nella vicina Torre Capodiferro che sorgeva sulla riva sinistra del Garigliano. Gran parte di quel prezioso materiale, però, andò purtroppo disperso a causa della distruzione della torre ad opera dei tedeschi in ritirata nel settembre del 1943.

Negli anni cinquanta un altro importante contributo fu dato dall’allora giovane archeologo Baldo Conticello che tentò, purtroppo senza riuscirci, a causa della solita carenza di fondi, e pur con la disponibilità da parte delle autorità inglesi, di far spostare il cimitero di guerra, per poter proseguire gli scavi in quella parte della città.
In effetti, l’attuale Comprensorio Archeologico portato alla luce comprende solo una parte della città, che resta ancora da esplorare. Se sono stati liberati dal terreno, come già ricordato, il primitivo Castrum, una parte della Via Appia fiancheggiata dai portici, il foro Repubblicano e il Teatro, restano ancora da far emergere dall’oblio dei secoli, interi quartieri e imponenti domus. Fra avvenuto, infatti, che nel corso del tempo, Minturnae era via via cresciuta, divenendo da città di tufo in epoca repubblicana, a città di pietra e marmo in età imperiale e, infine, di mattoni nel periodo adrianeo, arricchendosi di sempre più prestigiosi ed imponenti edifici.

Una ennesima proposta di scavo completo fu portato avanti nel 1991 con una variante al Piano Regolatore Generale di Minturno, sull’onda emotiva del restauro allora in corso del ponte Real Ferdinando. L’idea era quella di realizzare finalmente un Parco e Museo Archeologico, comprendente l’intera città, con lo spostamento del cimitero inglese e dell’attuale tracciato della Via Appia (nuova), e inglobando la parte terminale dell’acquedotto. Dopo tanti e infruttuosi tentativi, forse è maturo il tempo per realizzare quanto Minturno e i comuni vicini attendono da troppo tempo.